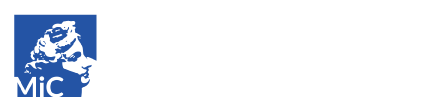Luogo: Catania, Piazza Dante Alighieri 32
Autore: Giancarlo De Carlo; Antonio Leonardi (Collaboratore Ufficio Tecnico UNICT); Susanne Wettstein, Micael Costantin, Andreas Singer, Daniele Taddei (Collaboratori, progetto guida per il recupero del complesso); Susanne Wettstein (Collaboratrice, la nuova centrale termica); Monica Mazzolani (Collaboratrice, Il Giardino dei Novizi); Susanne Wettstein, Giovanna Di Loreto (Collaboratrici, Il Giardino di via Biblioteca); Pippo Amadore, Paolo H. Casiglioni, Marco Ceccaroni, Manami Ito, Monica Mazzolani, Micael Taylor (Collaboratori, Aule, Laboratori e Auditorium); Pippo Amadore, Marco Ceccaroni, Daniele Leonardi, Roberto Rosada (Collaboratori, Corridoio dell’orologio e ambienti a sud-est del Monastero); Carmelo Russo (Strutture).
Cronologia: 1984 | 2005
Itinerario: Progettare il mutamento
Uso: Sede Universitaria

Nei primi anni Ottanta, Il Comune di Catania dona l’ex Monastero dei Benedettini, uno dei più grandi complessi barocchi della Sicilia, all’Università, al fine di attuare un piano di funzionalizzazione e restauro che avrebbe consentito di ospitare all’interno dell’edificio le facoltà umanistiche dell’Ateneo. Il rettore invita l’architetto Giancarlo De Carlo (già distintosi per la realizzazione del complesso universitario di Urbino), Roberto Pane e Piero Sampaolesi a far parte della commissione di valutazione per un concorso di idee finalizzato alla raccolta di progetti per la trasformazione del complesso. In un secondo momento De Carlo diviene consulente per la fattibilità dell’opera e, in ultimo, incaricato per la redazione del progetto.

Il complesso è sito in cima alla collina di Montevergine. Il cantiere da cui prende vita l’impianto barocco inizia a seguito del terremoto del 1693 e prosegue fino all’eversione dell’asse ecclesiastico avvenuta nel 1866, senza giungere a compimento. L’edificio, frazionato e adibito a diverse funzioni, giunge nelle disposizioni dell’Università in condizioni piuttosto critiche. De Carlo si confronta con una preesistenza stratificata, innestando le nuove funzioni nel massimo rispetto dell’edificio, operando la sottrazione degli elementi aggiunti in epoca contemporanea e ponendo il proprio intervento come un nuovo strato al palinsesto. Essendo l’edificio composto da elementi eterogenei, tra loro accostati, allo stesso modo le soluzioni progettuali si informano a questa eterogeneità, trovando soluzioni differenziate.
Gli spazi per la didattica e per la ricerca sono collocati negli ambienti intorno ai due chiostri, un nuovo corpo di fabbrica ospita sale studio e auditorio, gli spazi aperti, grazie all’inserimento di nuovi collegamenti orizzontali e verticali, divengono elemento portante del nuovo schema funzionale.

Disposto in asse con la chiesa, incastrato tra l’imponente vano absidale e il banco basaltico formatosi a seguito della colata che distrusse la fabbrica cinquecentesca, si trova il Giardino dei Novizi. Lo spazio, originariamente utilizzato per trascorrere delle pause all’aperto, non muta la sua funzione, ma è totalmente ripensato. Alcuni elementi, come la pergola impostata su colonne e i sedili in pietra calcarea, permangono, inserendosi all’interno di un rinnovato sistema organizzativo. Lo spazio si articola con un’alternanza di giardini e terrazze disposti intorno a percorsi rivestiti in basalto. Al di sotto del giardino è realizzata la centrale termica, i cui camini metallici sbucano dal piano di calpestio con delle sagome zoomorfe stilizzate.

Il cantiere della Centrale termica si conclude nei primi anni Novanta con la realizzazione della scala che connette il Giardino dei Novizi direttamente agli ambienti di controllo. Con un’altezza superiore a dodici metri, la scala si sviluppa su una rampa elicoidale a direttrice inclinata, racchiusa all’interno di un volume a sagoma troncoconica piantato sul banco lavico, l’inclinazione della direttrice è denunciata da una piccola feritoia che consente l’illuminazione naturale. La difficile realizzazione delle carpenterie per la costruzione della scala è stata seguita direttamente da De Carlo con la collaborazione dell’architetto Antonino Leonardi dell’Ufficio tecnico dell’Università, che si affiancò al progettista garantendo la costante presenza in cantiere.

La superficie che protegge gli ambienti della centrale termica dall’esterno è costituita da una facciata specchiante, realizzata con lastre di vetro bloccate a pavimento e a soffitto con dei telai metallici.

Le lastre specchianti, sono composte in modo da formare una superficie sfaccettata con andamento irregolare e spigoli vivi. La superficie rievoca le formazioni basaltiche generate dalle colate laviche, ben visibili nella zona su cui insiste il convento. In particolare una lingua di lava nel 1669, lambì l’originaria fabbrica cinquecentesca, prima che il terremoto del 1693 la distruggesse quasi completamente. Oltre a rievocare la pietra lavica, le superfici specchianti consentono un reciproco dialogo tra l’edificio barocco e l’inserto di nuova costruzione.

L’intero impianto progettuale è innestato sulle strutture preesistenti. Gli interventi realizzati consentono una nuova percezione dello spazio grazie alla realizzazione di collegamenti tra le varie parti della costruzione. Uno dei rari elementi di nuova realizzazione è l’auditorio, collocato nell’angolo ovest del complesso, al limite esterno dello spazio di pertinenza del monastero. L’ambiente, di forma quadrangolare, si innesta tra le costruzioni preesistenti: la distribuzione planimetrica si adatta alle condizioni del sito rispettando i lacerti murari e la roccia lavica visibili dall’interno della sala. L’accesso è ricavato da uno scavo disassato praticato nello spigolo prospicente il convento.

Gli spazi adibiti alla didattica e alla ricerca, sono gli originari ambienti di vita del monastero, articolati intorno ai due chiostri.
Le differenti destinazioni d’uso attribuite all’edificio dalla soppressione dell’asse ecclesiastico all’attuale destinazione a sede universitaria, avevano comportato la realizzazione di diversi adattamenti e frazionamenti dei volumi. De Carlo realizza una preliminare operazione di sottrazione di tutti gli elementi aggiunti, inserendo nuovi elementi funzionali all’utilizzo universitario. Gli spazi di distribuzione sono frazionati in altezza, con solai realizzati in legno e metallo, per trasformarli in postazioni di studio.

L’articolazione su diverse altezze dei piani di calpestio consente un costante contatto diretto con gli spazi aperti, grazie alle aperture vetrate. L’opportuno distanziamento delle nuove strutture dalle mura del monastero consente un costante contatto visivo tra i diversi ambienti e con gli spazi esterni.

L’intero progetto distributivo è informato dalla flessibilità di fruizione degli spazi, gli elementi di collegamento tra i diversi livelli, che talvolta potrebbero apparire sovrabbondanti, costituiscono un elemento determinante per l’agevole fruizione di uno spazio per sua natura impostato molto rigidamente.


Altro elemento con cui il progettista ha dovuto confrontarsi sono le permanenze archeologiche presenti nell’area in cui è stato costruito il monastero. La collina di Montevergine, posta in posizione predominante rispetto alla città e al mare, era il luogo dove sorgeva l’acropoli della città greca. Scavi archeologici condotti negli anni Settanta del Novecento ne hanno portato in luce alcuni resti sulla piazza prospicente il convento e all’interno dell’area. De Carlo si confronta con la preesistenza archeologica in diversi punti tra cui l’ingresso e gli spazi seminterrati, all’interno dei quali sono realizzati dei percorsi sospesi che ne consentono la fruizione.