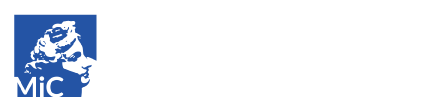Luogo: Bologna,Via Bartolomeo Maria Dal Monte, 14
Autore: Giuseppe Vaccaro; Franco Palpacelli, Guido Cavani, Carlo Tornelli (collaboratori)
Cronologia: 1958 | 1967
Itinerario: Spazio sacro e memoria
Uso: chiesa

La Chiesa di San Giovanni Bosco, progettata dall’architetto bolognese Giuseppe Vaccaro tra il 1958 e il 1967, si inserisce nel contesto del movimento bolognese per l’architettura sacra moderna promosso dal cardinale Giacomo Lercaro: la chiesa infatti risponde ai nuovi criteri liturgici emersi con il Concilio Vaticano II, riformulando lo spazio ecclesiale in funzione della partecipazione attiva dell’assemblea.

Nel 1955, l’Arcidiocesi di Bologna ha avviato un programma per la costruzione di nuove chiese nelle periferie in forte espansione, tra queste quella di San Giovanni Bosco è stata affidata direttamente all’architetto Giuseppe Vaccaro. La scelta nasce dalla volontà del cardinale Lercaro di coniugare modernità e spiritualità, dotando le nuove parrocchie di edifici capaci di diventare riferimenti urbani e simbolici per le comunità locali.

L’edificio si articola come una successione di prismi geometrici puri, ma la differenziazione materica tra le parti ne spezza la compattezza volumetrica. Tre sono gli elementi fondamentali della composizione: la facciata in vetro che introduce la luce nell’interno sacro, creando un’atmosfera solenne e meditativa; gli articolati piani in mattoni che si alzano, si abbassano e si piegano catturando la luce e segnando le percorrenze; la copertura metallica, sostenuta da una struttura reticolare a vista.


Il campanile è uno dei volumi puri che articolano la composizione e richiama le torri medievali bolognesi e il linguaggio di altri progetti dello stesso Vaccaro. Con la sua imponente verticalità diventa un segnale urbano visibile da lontano, conferendo alla chiesa una forte valenza civica.

Il fronte principale della chiesa si presenta come una composizione geometrica essenziale dove la grande facciata vitrea, scandita da una griglia metallica, lascia filtrare la luce all’interno, mentre la croce in ferro, sospesa e integrata nella struttura reticolare orizzontale, si staglia con forza simbolica, segnando il punto di ingresso dei fedeli.
La chiesa presenta un impianto quadrangolare che richiama, rielaborandola, la spazialità centripeta delle chiese a pianta centrale. Qui lo spazio tradizionale dell’aula sacra è deformato mediante la ripetuta piegatura delle pareti perimetrali, creando nicchie che accolgono i poli liturgici, l’abside, le cappelle feriali, gli altari minori e il fonte battesimale.

All’interno della chiesa i materiali, la luce e i colori esaltano la sacralità dello spazio.
L’ambiente si caratterizza per una sapiente gestione della luce naturale, che filtra attraverso lucernai in cemento bianco, vetrate trasparenti e policrome.

Le vetrate policrome generano effetti di luce dinamici, in particolare nel battistero, dove il colore rossastro delle finestre amplifica il senso di raccoglimento spirituale.

Il marmo bianco di Romania dell’altare maggiore emerge in contrasto con il granito grigio-verde di Serizzo di Valmàsino della pavimentazione, creando un punto focale per la liturgia.

Il rame ossidato della copertura interna ritmata da lamelle enfatizza la geometria irregolare dell’insieme e valorizza gli effetti di luce.
Gli arredi liturgici sono opera di Padre Costantino Ruggeri, artista e scultore di fama internazionale, che arricchisce la chiesa con elementi essenziali ma potenti nel loro significato simbolico.