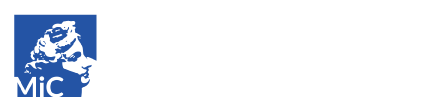Luogo: Baranzate (MI), Via della conciliazione 22-24
Autore: Aldo Favini, Angelo Mangiarotti, Bruno Morassutti; Gono Cosentino (sculture); Giulio Barazzetta con Aldo Favini, Angelo Mangiarotti, Bruno Morassutti, Anna Mangiarotti, Ingrid Paolettti, Tito Negri, Giancarlo Chiesa, Enrico Malli (restauro)
Cronologia: 1956 | 1958 ; 1979 | 1980 (campanile); 2006 | 2015 (restauro)
Itinerario: Spazio sacro e memoria
Uso: Luogo di culto

La Chiesa Parrocchiale di Baranzate è uno degli esempi di “rinnovamento dell’architettura sacra” promossi dal Cardinale Giovanni Battista Montini alla metà degli anni Cinquanta. Montini per far fronte alla sempre crescente espansione della città di Milano e al relativo bisogno di edifici religiosi, si affida ad architetti quali Ponti, Figini e Pollini, Gardella e alti ancora che propongono e realizzano soluzioni innovative aprendo un dibattito molto acceso. L’edificio pensato per Baranzate dagli architetti Mangiarotti e Morassutti sorge alla periferia nord-ovest della città ed è uno degli edifici più discussi promossi da Montini. Interamente finanziato da privati è l’unico episodio di architettura sacra nella carriera dei due architetti che per la realizzazione delle strutture si avvalsero della collaborazione dell’ingegnere Aldo Favini. La chiesa è costruita con accorgimenti ingegneristici che hanno consentito la realizzazione di pareti esterne in moduli di vetro traslucido che ne costituiscono la connotazione predominante.


La costruzione molto semplice consta di un parallelepipedo a base rettangolare delle dimensioni di 18 x 24 m che ospita l’aula liturgica, impostata su un podio, all’interno del quale trovano posto la cripta, la sagrestia e il fonte battesimale. Affiancato alla chiesa sorge il campanile in metallo corten realizzato in una seconda fase tra il 1984 e il 1985 dallo stesso Morassutti in collaborazione con Favini. L’area di pertinenza della chiesa è circondata da un recinto in calcestruzzo e ciottoli di fiume all’interno del quale sono incastonate le stazioni della via crucis realizzate dallo scultore Gino Cosentino.


L’aula è un unico ambiente all’interno del quale sono svelati tutti i segreti della struttura non leggibili dall’esterno. Quattro pilastri in calcestruzzo armato sormontati da due travi gettate in opera, sorreggono la copertura piana realizzata con elementi in calcestruzzo prefabbricato. Le pareti sono interamente realizzate in vetro, costituite da elementi modulari di forma rettangolare composti da due lastre vitree tra le quali è interposto un materiale biancastro che rende le pareti traslucide consentendo l’ingresso di una luce intensa ma soffusa. Due sottili fasce di vetro trasparente staccano le pareti dalla copertura e dal suolo, contribuendo alla percezione smaterializzata dei diversi elementi della costruzione.


Gli elementi d’arredo sono disegnati dagli stessi progettisti. Lo straordinario effetto complessivo della realizzazione suscita, subito dopo l’inaugurazione, critiche e ammirazione, sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista architettonico e formale. Il materiale interposto tra le pareti vetrate subisce diverse alterazioni, è sostituito due volte l’ultima in occasione dei restauri condotti tra il 2006 e il 2015 con la partecipazione degli stessi progettisti al gruppo di lavoro.


Il percorso del fruitore si conclude con l’uscita dall’aula attraverso una porta scorrevole posizionata al centro del fronte principale, alla quale segue una larga rampa che accompagna i fedeli al di fuori dell’area di pertinenza della chiesa.
Le travi in cemento precompresso che sorreggono la copertura costituiscono il coronamento dell’edificio. In particolare la sezione a forma di X delle sei travi, connota il prospetto principale. Lo spazio vuoto tra gli elementi è tamponato da lastre di vetro che la sera, grazie all’illuminazione interna, lasciano intravvedere i lacunari in calcestruzzo del piano di copertura.


La rilevanza dell’edificio ha portato al riconoscimento e alla relativa dichiarazione d’importante interesse, con Vincolo 13.1.2003 del Ministero Beni e Attività Culturali. Tra le motivazioni che hanno portato all’apposizione del vincolo: la rappresentatività della ricerca strutturale e la scelta di un linguaggio basato sull’uso della luce, oltre ad essere il primo edificio ecclesiastico in cui è stato sperimentato l’utilizzo di calcestruzzo armato prefabbricato.


La deperibilità degli elementi di schermatura contenuti all’interno delle lastre di vetro è stato il motivo principale che ha motivato le azioni di restauro che hanno coinvolto l’intero edificio. Tale degrado aveva fortemente alterato l’effetto visivo ricercato dai progettisti e oggetto di numerosi dibattiti che è valso all’edificio il nome di “Chiesa di vetro”.