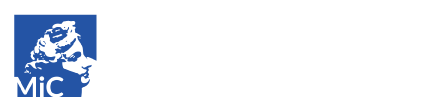Luogo: Motta Sant’Anastasia (CT), SP 13, 25
Autore: Diez Brandi; Hans Wimmer (sculture)
Cronologia: 1961 | 1965
Itinerario: Spazio sacro e memoria
Uso: Cimitero militare

Il cimitero Militare Tedesco di Motta Sant’Anastasia nasce a seguito dell’accordo italo-tedesco sulle tombe di guerra, stipulato nel 1945, il sacrario raccoglie tutte le vittime tedesche cadute sul suolo siciliano nel corso della seconda Guerra Mondiale. Il sacrario sorge all’interno di una zona a prevalente utilizzo agricolo, in prossimità del centro abitato del comune di Misterbinaco ed è stato costruito dalla Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge associazione che si occupa delle onoranze funebri dei soldati tedeschi. Il progetto del cimitero è stato redatto dall’architetto tedesco Diez Brandi nativo di Maburgo che ne ha seguita anche l’esecuzione.
Formatosi a Stoccarda, Brandi è docente a Praga, Monaco di Baviera e Istanbul ed è attivo in qualità di progettista prevalentemente a Göttingen dove aveva sede il suo studio professionale (G. Di Benedetto 2018). Il progetto originario prevedeva un blocco unico di forma rettangolare, con pareti in mattoni e un cordolo sommitale in travertino. Il volume totalmente chiuso all’esterno era dotato di una sola apertura dalla quale si accedeva a un atrio dotato di una scala che porta a un livello rialzato articolato in cinque camere. L’edificio oggetto di svariati interventi, intorno agli anni Ottanta è privato dell’atrio, evento che ne trasforma definitivamente l’immagine esterna (G. Di Benedetto 2018).

Il sacrario si sviluppa su due livelli, il livello inferire, inaccessibile nel quale sono disposte le salme dei 4550 soldati tedeschi, il livello superiore è un grande recinto suddiviso in cinque celle “Kammern” tra loro comunicanti.
La prima è denominata camera dei compagni è la più piccola, di forma quadrata, all’interno centralmente sono disposti una lastra soprelevata al di sopra della quale è adagiata una statua bronzea, raffigurante un uomo morente, realizzata dallo scultore Hans Wimmer e una targa con i nomi dei soldati ivi sepolti.


I restanti quattro ambienti sono dedicati ai caduti rinvenuti su tutto il territorio siciliano, suddivisi in base al luogo di ritrovamento. Le corti assumono quindi i nomi di alcune provincie e rappresentano ciascuna una porzione di territorio siciliano: la corte Palermo (ospita anche Trapani e Agrigento), la corte Caltanissetta (ospita anche Siracusa e Ragusa), la corte Messina (ospita anche Enna) e la corte Catania. Quest’ultima unica differente per dimensioni più stretta e allungata, tale forma è condizionata dalla dimensione della camera dei compagni che ne definisce la misura del lato corto. La geometria della corte determina anche la posizione delle lapidi in questo caso sedici affrontate e disposte su due file parallele.


Le restanti tre corti occupano interamente il resto dello spazio, sono identiche per dimensioni e riportano all’interno lo stesso numero di lapidi, nove per stanza, decentrate verso ovest, per lasciare spazio al passaggio tra una corte e l’altra. Il sacrario è concepito per vivere l’esperienza del ricordo dei caduti in guerra, in una condizione di quasi totale isolamento. I materiali utilizzati contrastano fortemente tra loro, la semplicità delle cortine in mattoni con l’eleganza del marmo di carrara utilizzato per le pavimentazioni e ancora il candore del marmo in contrasto con il colore scuro delle lapidi di pietra lavica su cui sono incisi i nomi dei soldati.


L’edificio a causa della sua conformazione e per difetti di progettazione ha richiesto diversi interventi nel tempo, in particolare gravi problemi di tipo strutturale hanno portato a una consistente campagna di interventi intrapresa nel 2002 dalla Agenzia federale di soccorso tecnico. Tali interventi, oltre alla realizzazione di consistenti elementi di sostegno in fondazione e lungo il perimetro esterno dell’edificio, hanno portato alla demolizione di una porzione pari a due metri di tutti gli alzati e alla sostituzione dell’originale cordolo in travertino con un cordolo in calcestruzzo armato aggettante sia internamente che esternamente. Tali modifiche sommate alle mutilazioni degli anni Ottanta, hanno portato a una significativa alterazione dell’immagine originaria dell’edificio (G. Di Benedetto 2018).