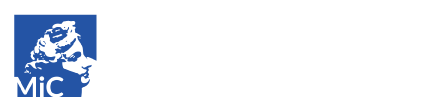Luogo: Maccagno con Pino e Veddasca (VA), Via Leopoldo Giampaolo, 1
Autore: Maurizio Sacripanti, Giuseppe Noris, Riccardo Colella
Cronologia: 1979 | 1992
Itinerario: Nuove architetture per la nuova società – L’architettura contemporanea nel paesaggio
Uso: Museo

Il museo di Arte contemporanea di Maccagno prende origine da un’idea dell’artista Giuseppe Vittorio Parisi, il quale, rientrando da Roma nella città d’origine, immagina, in collaborazione con l’amministrazione comunale, un centro per l’arte contemporanea fuori dei tradizionali circuiti culturali. La proposta è fortemente favorita dalla decisione dell’artista e della moglie Wanda Valle di donare al Comune la propria collezione di opere d’arte. Nel 1979 prende avvio l’iter per la creazione della “Fondazione Parisi – Valle” e la realizzazione del museo destinato a ospitarne la collezione. È lo stesso Valle, supportato dal parere di Bruno Zevi, a proporre un team progettuale composto dall’architetto romano Maurizio Sacripanti, dall’ingegnere Luigi Nori che curerà la direzione lavori e dall’architetto Riccardo Colella che curerà la progettazione degli interni.


La progettazione dell’edificio è fortemente legata alla scelta del luogo di realizzazione. La costruzione è collocata in prossimità della sponda ovest del Lago Maggiore e si sviluppa grazie a una piastra sospesa su pilastri che congiunge i due argini del torrente Giona.
L’edificio, espressione della ricerca di Sacripanti, incentrata sulla sospensione degli edifici nello spazio e nel tempo, dispiega molta della carica espressiva nello sviluppo di un continuo dialogo con l’ambiente naturale circostante. La permeabilità alla luce naturale, la possibilità di volgere lo sguardo al cielo e al fiume offerte dall’interno dell’edificio e la creazione di una terrazza belvedere gradonata affacciata sulla foce del terrente, costituiscono parte integrante dell’esperienza offerta al visitatore, che può contemporaneamente immergersi nell’arte e nella natura.


L’attraversamento e la sospensione possono essere esperite dal fruitore internamente o esternamente e a diversi livelli. Il massiccio volume in calcestruzzo armato è segnato da tagli orizzontali non immediatamente percepibili esteriormente, che generano una sorta di fusione tra interno ed esterno.


L’ardita articolazione strutturale è risolta dall’ingegnere Noris impostando la piastra di forma quadrangolare su nove pilastri fondati nell’alveo del torrente. Il volume contiene l’ambiente unico dello spazio espositivo, definito da una fascia finestrata che rende la piastra di copertura una superficie fluttuante popolata da insoliti elementi che scandiscono il percorso della terrazza. Le tre famiglie di elementi sono ripetute serialmente e a esse è affidato il compito di veicolare, con modalità differenziate, la luce naturale all’interno dello spazio espositivo.

Le grandi travi a sezione rettangolare che sostengono la copertura sono realizzate a sbalzo e poggiate su pilastri disposti all’interno dell’edificio. Questa soluzione consente di realizzare, in corrispondenza del prospetto a valle, un sovvertimento del sistema dei pesi, smaterializzando il volume dall’alto verso il basso. L’assenza dei supporti all’incrocio delle travi e il taglio diagonale che genera le finestrature conferiscono alla piastra di copertura il ricercato effetto di sospensione.

I temi dell’attraversamento e della sospensione sono enfatizzati da segni orizzontali che accompagnano il fruitore lungo tutto il percorso. Agli attraversamenti esterni corrispondono tagli nella piastra di appoggio che consentono il contatto visivo con il corso d’acqua sottostante.


Le finestre a nastro poste all’altezza dell’osservatore, sono concepite con sagoma inclinata, in modo da consentire un duplice contatto visivo con l’intorno e con il torrente.

Unico elemento d’interruzione all’interno dello spazio espositivo è un pozzo luce, di forma quadrata, che attraversa il blocco verticalmente a tutta altezza, consentendo la visione del cielo e del corso d’acqua.
L’interruzione verticale dello spazio interno consente l’istallazione di alcuni spazi funzionali, come servizi igienici e uffici, che si addossano su due lati del pozzo luce. I restanti due lati presentano una doppia inclinazione, invitando il fruitore ad un contatto con gli elementi naturali circostanti.

Il cantiere si protrae a lungo a causa della mancanza di fondi a disposizione delle amministrazioni locali. Nonostante i ritardi nella realizzazione, l’opera ancora in compiuta incontra il consenso della critica: nel 1992 il progetto è insignito del premio IN/ARCH.
Gli interni saranno ultimati dopo la scomparsa di Sacripanti e Noris.