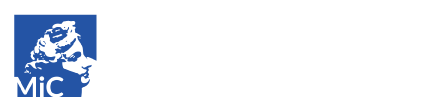Luogo: Campi di Bisenzio (FI)
Autore: Giovanni Michelucci; Enzo Vannucci, Ivo Tagliaventi (strutture)
Cronologia: 1960| 1964
Itinerario: Spazio sacro e memoria
Uso: edificio per il culto

La chiesa venne costruita per ricordare i numerosi caduti sul lavoro causati della costruzione dell’Autostrada del Sole. Il luogo venne scelto simbolicamente come punto mediano tra Milano e Napoli, le due città collegate dall’imponente infrastruttura. L’incarico per la realizzazione della chiesa viene dato all’architetto Giovanni Michelucci nel settembre del 1960.


L’impianto è caratterizzato da tre diversi corpi giustapposti, distribuiti secondo l’asse est-ovest. La galleria battesimale conclusa ad ovest dal corpo del battistero ad andamento curvilineo, il nartece scandito da alcuni pannelli dedicati ai santi patroni delle città messe in collegamento dall’Autostrada del Sole, sui pannelli in bronzo troviamo raffigurati Sant’Ambrogio (Milano), Santa Giustina (Piacenza), Sant’Ilario (Parma), Santi Crisanto e Daria (Reggio nell’Emilia), San Geminiano (Modena), San Petronio (Bologna), Santi Pietro e Paolo (Roma), San Silverio (Frosinone), San Michele Arcangelo (Caserta), San Gennaro (Napoli) la lista esclude Firenze, il cui protettore, San Giovanni Battista, è lo stesso dedicatario della Chiesa dell’Autostrada e trova speciale rilievo nella vetrata all’interno dell’aula.

I materiali utilizzati per la realizzazione di questo edificio sono per le murature perimetrali la pietra di San Giuliano, ricavata dalle cave del gruppo montuoso San Giuliano situato fra il Serchio e il Val d’Arno inferiore pisano, il cemento bianco della Sardegna per le parti strutturali, per la copertura il rame e per gli interni marmo e pietra.

Nell’approcciarsi a questo edificio lo si accosta nella forma a quella di una tenda, lo stesso Michelucci afferma:” La forma generale è quella di una tenda, il che può significare, analogicamente, il “transito”, e non la dimora definitiva degli uomini sulla terra. Dico “può” perché questa forma è un risultato e non una premessa. Non sono cioè partito dall’idea della tenda per assoggettarle poi la struttura interna; ma la forma ha cominciato a delinearsi in conseguenza del tessuto interno. Ed è allora che un versetto di San Paolo nella Epistola ai Corinzi […] mi ha aiutato a precisare la forma stessa»

L’intorno della chiesa è una zona coltivata a prato, leggermente ondulata, nella quale sono piantati alcuni ulivi, pioppi e pini marittimi. Il marciapiede che circonda la chiesa è realizzato in lastre di pietra arenaria.

La muratura perimetrale per la sua colorazione chiara e per la compattezza materica funge da fascione che avvolge la chiesa, tanto che le aperture e le feritoie sono molto contenute. Il muro perimetrale è inoltre caratterizzato da un movimento impressogli dalla forma sinuosa, soprattutto per alcuni tratti sul lato nord e ovest – ma anche a sud, in corrispondenza dell’ampio arco di cerchio sporgente che lascia intuire il battistero. La morbida forma curvilinea non rinuncia a spigoli vivi e forme geometriche, soprattutto a est e si frastaglia su tre livelli dal lato nord-ovest, in corrispondenza della sacrestia e della vetrata che sormonta l’altare maggiore.




Dal sagrato, posto sul lato est, si accede al nartece collocato nello spazio antistante l’aula. Ma se nelle chiese antiche il nartece era per lo più un portico a ridosso della facciata in diretta comunicazione con il chiostro all’aperto, nella Chiesa dell’Autostrada, esso, pur mettendo in dialogo l’aula e il chiostro alberato, è in sostanza una specie di galleria d’accesso all’aula.

Nella parte sud troviamo il battistero avente forma tondeggiante ad evocare antichi Battisteri che nella loro antica concezione erano pensati come corpi autonomi e staccati dalla chiesa, in questo caso il battistero è al contempo autonomi e legato al corpo principale, poiché vi si accede attraverso una galleria indipendente, con accesso proprio che però è messa in relazione con lo spazio del nartece attraverso il chiostro alberato.

Attraverso il nartece si accende nell’aula vera e propria organizzata secondo uno schema che ricorda la croce latina, ma che Michelucci interpreta in maniera innovativa. Infatti osservando l’impianto planimetrico si può osservare come l’altare principale non sia collocato all’incrocio tra navata e transetto piuttosto trovi la sua collocazione nella parte terminale di quello che appare essere uno dei bracci del transetto. A destra e a sinistra dell’altare, in posizione più riservata sono posti due cappelle secondarie. L’impressione che si ha entrando nella chiesa è quella di accedere in uno spazio unico collettivo in cui però si ha la possibilità di trovare punti più riservati in cui trovare un diverso raccoglimento.

Michelucci sottolineando la propria responsabilità di progettista chiarisce: “non mi sono preoccupato di far sì che la nuova costruzione si presentasse come un nuovo “pezzo” architettonico compiaciuto di sé stesso: uno dei tanti “capolavori” o “monumenti” che si realizzano per l’ammirazione degli esteti, nel disinteresse massimo della popolazione (che, d’altra parte, avvezza ad essere considerata incompetente, ha finito col disinteressarsi quasi di proposito); ma mi sono […] preoccupato di fare un’opera il cui linguaggio fosse alla portata di tutti, nella quale ogni uomo potesse sentirsi a suo agio, non costretto a dover capire quel che l’architetto ha voluto fare, ma forse invece portato a rendersi conto che l’architetto ed i collaboratori tutti (dal calcolatore al capocantiere, agli scalpellini, ai muratori, ai manovali) sono per prima cosa degli uomini, che hanno un loro mestiere ed un senso di responsabilità verso il loro lavoro allo scopo di poter rispondere, con quello che fanno, alle necessità materiali e spirituali degli altri uomini, e insieme alle loro stesse. Ho cercato inoltre di evitare suggestioni “mistiche” in un’opera la cui “suggestione” deve scaturire da una sua riscoperta necessità, da una sua adesione profonda al suo significato spirituale”.

L’aula liturgica è dominata dalla possente intelaiatura in cemento armato precompresso realizzata a sostegno della copertura che a tratti è realizzata con superfici rettilinee e a tratti con superfici curvilinee, a ricordare l’effetto di una tenda che sostenuta da puntelli non si tende in tutte le parti in maniera uniforme.


Tutta la complessa volumetria che caratterizza questa costruzione convoglia lo sguardo verso l’altare centrale e verso l’unica vetrata di dimensioni significative in cui è raffigurato San Giovanni Battista.