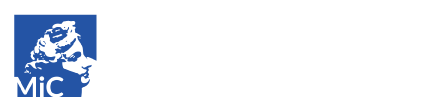Luogo: Carpi (MO), Piazza dei Martiri n.68
Autore: BBPR (Gian Luigi Banfi, Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressutti, Ernesto Nathan Rogers), Albe e Lica Steiner; Renato Guttuso, Giuseppe Lanzani (collaboratori); Nelo Risi, Primo Levi (consulenti); Renato Guttuso, Corrado Cagli, Alberto Longoni, Fernand Léger, Pablo Picasso (artisti)
Cronologia: 1963 | 1973
Itinerario: L’architettura contemporanea nel paesaggio – Spazio sacro e memoria
Uso: monumento – museo

Il Museo monumento al deportato nei campi di sterminio nazisti di Carpi, inaugurato nel 1973, nasce come luogo della memoria per commemorare le vittime del nazifascismo, con un’attenzione particolare ai deportati italiani nei campi di concentramento. Il museo si inserisce in un territorio fortemente segnato dalla tragedia della deportazione. Nelle vicinanze di Carpi sorgeva il Campo di Fossoli, struttura utilizzata prima come campo di prigionia per soldati alleati, poi come campo di raccolta per ebrei e oppositori politici destinati alla deportazione nei lager nazisti. La sua esistenza ha segnato profondamente la memoria locale, spingendo le istituzioni e la comunità civile a interrogarsi sulla necessità di preservare e trasmettere il ricordo di quei tragici eventi.
Nel secondo dopoguerra la città di Carpi divenne così un punto di riferimento per la memoria della deportazione. La volontà di creare un luogo che potesse testimoniare gli orrori della guerra e rendere omaggio ai deportati si concretizzò negli anni ’60 con il concorso di progettazione e poi con l’incarico affidato allo studio BBPR, un gruppo di architetti legato direttamente alla Resistenza. Infatti Gian Luigi Banfi era morto nel campo di concentramento di Gusen nel 1945, mentre Lodovico Barbiano di Belgiojoso era sopravvissuto dal campo di Mauthausen.
L’approccio dello studio BBPR al progetto è stato guidato da un’idea di architettura che potesse essere monumentale e profondamente evocativa, senza scadere nella retorica celebrativa. Il risultato è stato un museo concepito come spazio di riflessione e testimonianza, in cui architettura, arte e memoria si intrecciano in un percorso di forte impatto emotivo.
Il museo è ospitato all’interno di Palazzo dei Pio, nel centro storico di Carpi. Si sviluppa in un percorso espositivo caratterizzato da ambienti essenziali e austeri, pensati per immergere il visitatore in un’atmosfera di raccoglimento, riflessione e ricordo.


Gli spazi preesistenti del Palazzo sono adattati a percorso museale con un uso calibrato di materiali e forme. Il museo si articola su 13 sale, cui si aggiunge lo spazio esterno.
Il percorso espositivo è concepito come un’esperienza immersiva e di forte impatto emotivo. Le pareti sono incise con frasi di deportati e condannati a morte, testimonianze dirette che entrano in dialogo con il visitatore. Le parole rosse e nere rappresentano delle ferite ancora sanguinanti.


Il museo è arricchito da disegni e graffiti di importanti artisti, tra cui Longoni, Picasso, Guttuso, Cagli e Léger. Le loro opere contribuiscono a trasmettere il dolore e la resistenza dei deportati attraverso un linguaggio simbolico e potente.
L’inizio del percorso museale viene scandito dalla frase di Bertold Brecht: “E Voi, imparate che occorre vedere e non guardare in aria; occorre agire e non parlare. Questo mostro stava, una volta, per governare il mondo! I popoli lo spensero, ma ora non cantiamo vittoria troppo presto: il grembo da cui nacque è ancor fecondo.”

Il percorso museale prosegue con un graffito di Alberto Longoni, che raffigura un intricato intreccio di figure scheletriche dagli occhi spalancati e inquieti. Si susseguono poi un graffito di Renato Guttuso e uno di Corrado Cagli.

Successivamente il visitatore si trova immerso tra cimeli e gigantografie di fotografie curate da Albe e Lica Steiner per le teche espositive. Il riferimento al campo di Fossoli è affidato a una selezione di oggetti e immagini conservati nelle teche. In ogni sala, i frammenti delle lettere dei deportati stimolano la riflessione sulla lotta per la libertà e sull’addio alla vita, mentre le immagini a parete traducono visivamente il dramma della deportazione e dello sterminio.
Le teche espositive contengono alcuni oggetti appartenuti ai prigionieri, tra cui uniformi a righe, zoccoli, utensili come cucchiai e scatolette di alluminio, e un braccialetto inciso con il numero di matricola del deportato.


L’ultima sala, denominata Sala dei Nomi, è dominata dalle incisioni di circa 15.000 nomi di cittadini italiani caduti nei campi di concentramento e sterminio. Le pareti e le volte sono dense di nomi a rendere tangibile ed enorme il ricordo della tragedia


L’uscita del museo conduce attraverso il Cortile delle Steli, dove quindici stele in cemento armato, alte sei metri e incise con i nomi dei principali campi di concentramento nazisti, si ergono come lame taglienti, evocando senso di lutto e riflessione. Alla base di queste stele, che sorgono da un fossato, vi sono delle rose rosse a simboleggiare il sacrificio e la speranza.


Il Museo Monumento carpigiano a tutt’oggi sa raccontare le varie componenti della deportazione e si distingue per raffinatezza, sobrietà e incisività del disegno museale.