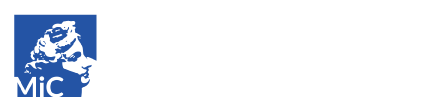Luogo: Ivrea (TO), quartiere Castellamonte, Via Jervis, 98-100
Autore: Marcello Nizzoli, Gian Mario Oliveri
Cronologia: 1954 | 1955
Itinerario: La casa in Italia tra costruzione e sperimentazione
Uso: Residenziale

L’edificio noto come “casa a 18 alloggi” sorge nel quartiere di via Castellamonte, oggi via Jervis, di Ivrea, un insediamento di abitazioni per dipendenti voluto da Adriano Olivetti nell’ambito del progetto di sviluppo edilizio di un’area prossima alle Officine ICO.
La nascita del quartiere avvenne nel 1940 con le prime sette case a schiera per famiglie numerose, di chiara matrice razionalista, progettate da Luigi Figini e Gino Pollini. Tra il 1950 ed il 1956 il quartiere venne ampliato con alcune realizzazioni di Marcello Nizzoli e Gian Mario Olivieri; i due architetti milanesi progettarono dapprima sei villette unifamiliari con giardino per dirigenti della Olivetti, successivamente due edifici a quattro alloggi e nel 1956 un ultimo complesso residenziale, la famosa “casa a 18 alloggi”, un edificio composto da tre blocchi edilizi, “distinti sul fronte verso via Jervis per forma, colore e uso dei materiali” (M. Bosica, 2019), realizzato nell’estremità ovest del quartiere, e destinato ad ospitare alloggi per dipendenti.


Dei tre edifici che compongono il complesso residenziale quello di destra presenta una maggiore articolazione del volume e della composizione architettonica, sia da un punto di vista tipologico che nell’uso dei materiali. La partizione orizzontale della facciata principale, caratterizzata dai bianchi parapetti dei terrazzi, definisce visivamente la zona dell’ingresso, con l’antistante parco giochi per bambini disegnato dallo stesso Nizzoli.

La casa a 18 alloggi conclude il ciclo delle realizzazioni nel quartiere Castellamonte degli architetti Nizzoli e Olivieri e rappresenta l’esito della ricerca tra composizione architettonica e linguaggio decorativo, tra complessità e sintesi unificatrice; “nella casa a 18 alloggi l’esperimento di mettere insieme un trittico di edifici per formarne uno è di per sé affascinante, soprattutto se essi differiscono nell’architettura del loro fronte principale. Se si continua l’esperimento sul fronte opposto e si ricerca questa volta l’unità anziché la diversità, risolvendo le contraddizioni, il gioco è fatto.” (G. M. Oliveri)


La zona dell’ingresso, con i suoi pilastri rivestiti da piccole tessere di ceramica di colore diverso, è caratterizzata da un mosaico raffigurante elefanti e altri animali della foresta; il tema del colore è una delle invarianti delle realizzazioni di Nizzoli ed Oliveri, in quanto “l’apporto del colore non deve considerarsi un correttivo dell’architettura, ma un complemento sostanzialmente coerente” per cui “un architetto concepirà sino dal nascere della sua opera un posto per l’inserimento di una pittura, di una scultura, o di un semplice colore.” (M. Nizzoli)

Il blocco centrale dei tre edifici si differenzia sia per l’altezza che per la finitura delle facciate, quasi a voler rappresentare un elemento di unione dei due corpi laterali tra loro molto diversi per forma, spazialità dei volumi e composizione architettonica. Questa funzione unificatrice del corpo centrale e messa in evidenza anche dall’uso di piastrelle di klinker colorate in blu, un gioco di colore attraverso il quale la decorazione diviene “funzionale, dal punto di vista espressivo, all’edificio.” (G. M. Oliveri)


La formazione e l’attività professionale di Nizzoli ed Oliveri, legata al mondo del design, della grafica e delle arti figurative, era in stretta connessione con la progettazione architettonica, convinti che la “decorazione sia strutturata all’edificio cioè tutt’uno con esso” (G.M.Oliveri).
Così la scelta di usare il colore in alcuni pilastri del porticato, l’uso diversificato dei materiali di rivestimento, come ad esempio le tessere di mosaico o il disegno di una balaustra in ferro, sono determinanti per definire un linguaggio architettonico concepito come “arte totale”.

Nella facciata laterale dell’edificio di destra, la continuità dei parapetti bianchi dei terrazzi lascia il posto a semplici balaustre in ferro verniciato, al fine di garantire un perfetto equilibrio volumetrico tra la parte vuota e la quinta muraria piena, realizzata nell’ottica della protezione delle abitazioni dalla esposizione verso nord.

L’edifico posto sul lato sinistro presenta una soluzione progettuale meno articolata rispetto agli altri due fabbricati; il prospetto, alquanto compatto, presenta parti decorative meno elaborate, lasciando alla finitura dei materiali il compito di scandire la partizione verticale della facciata.