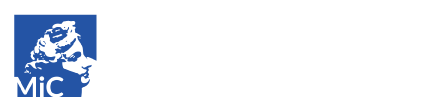Luogo: Gorizia, Cormons, Medea, Salita dell’Ara Pacis
Autore: Mario Bacciocchi con Leone Sirtori (collaborazione alla realizzazione)
Cronologia: 1950 | 1951
Itinerario: Spazio sacro e memoria
Uso: Monumento commemorativo

L’idea del monumento, successivamente denominato “Ara Pacis Mundi”, nasce su impulso del Comitato promotore per le onoranze a Redipuglia, costituitosi nel 1950, con a capo Tito Zaniboni, allora presidente della Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia. L’intenzione che dà impulso all’iniziativa è quella di realizzare un luogo simbolico che rappresenti tutti i caduti del secondo Conflitto monidiale. Differentemente dalle epigrafi e monumenti sorti in vari luoghi della nazione, questo monumento dovrà essere scevro di qualsiasi valore identitario, sia esso di razza, politico o nazionale. Il luogo prescelto è Colle Sant’Elia, promontorio che fronteggia il Sacrario militare di Redipuglia. L’idea viene fortemente avversata da diversi fronti, sia sul piano ideologico, sia per il luogo prescelto.
La pervicacia con cui il Comitato porta avanti l’iniziativa, fino ad arrivare all’allestimento del cantiere, spinge la Soprintendenza ad intervenire, convincendo i promotori a spostare il sito sulla non lontana collina di Medea.

L’incarico è da subito assegnato all’architetto Mario Bacciocchi, originario di Piacenza, che redige il progetto per un monumento molto articolato, da erigersi nel sito originariamente prescelto. Il comitato ritiene la proposta eccessivamente complessa e opta per una soluzione più essenziale che rappresenti un “altare della pace”, in modo da enfatizzare il significato simbolico dell’operazione, da cui il nome “Ara Pacis Mundi”. L’architetto, attenendosi alle indicazioni, progetta un monumento con articolazione molto semplice e incisiva. L’impossibilità di realizzarlo nel luogo per cui era stato concepito, non provoca comunque nessuna successiva modifica al progetto.

Il monumento sorge su un podio ed è costituito da un recinto alto tredici metri, definito da due setti a C interamente rivestiti con lastre di travertino, che si interrompono sui due fronti laterali con una fenditura centrale.
Il Fronte principale, rivolto a est, è costituito da dodici pilastri a base rettangolare tenuti insieme dall’architrave. Tale conformazione rende l’edificio permeabile all’accesso e alla vista: dall’esterno si percepisce infatti la presenza dell’ara di colore scuro.

L’altare, posto in corrispondenza del centro geometrico dell’edificio, con la sua altezza di cinque metri, incarna il valore simbolico che ha dato impulso a tutta l’operazione. Al suo interno è contenuta l’urna nella quale sono riposte zolle di terra provenienti da più di ottocento cimiteri militari italiani ed esteri e ampolle di acqua provenienti dai mari in cui si sono combattute battaglie. Nel corso del mese di aprile del 1951, in diverse località sono effettuati i prelievi delle zolle che saranno poi trasportate a Roma, presso il monumento al Milite ignoto. Il 4 maggio, l’urna raggiungerà la destinazione finale a Medea e il 6 maggio si terrà l’inaugurazione ufficiale del monumento.


Il differente trattamento dei due prospetti lunghi dell’edificio e la diversità cromatica tra il recinto e l’urna, sono volti a enfatizzare la presenza del sacello quale fulcro dell’attenzione. Sopra di esso è incisa la frase “l’odio produce morte, l’amore genera la vita”. Il prospetto est, con i pilastri liberi, lascia intravedere l’ara che, con il suo colore scuro, si staglia sul prospetto ovest, compatto e aperto solo nella parte inferiore per un’altezza di tre metri, utile ad agevolare il passaggio delle persone e dei raggi luminosi radenti il pavimento.
I due tagli verticali, che coprono tutta l’altezza del recinto nei prospetti corti, inquadrano l’altare intercettandolo in direzione assiale.

Il trattamento superficiale è realizzato con rivestimento in lastre di travertino. La disposizione delle lastre è differenziata tra superficie interna e superficie esterna: sono infatti disposte verticalmente all’interno e orizzontalmente all’esterno, quasi a sottolineare la totale astrazione del fortilizio militare e quindi della stessa tecnica costruttiva. I due prospetti corti presentano alcuni filari con delle interruzioni ritmate che ricordano feritoie cieche.


L’architetto, al fine di ammorbidire la rigida immagine di fortilizio, utilizza un particolare trattamento dei quattro angoli che incorniciano i prospetti principali. Questi presentano una lieve flessione verso l’esterno e un leggero arrotondamento dello spigolo, accorgimento che conferisce plasticità all’immagine dell’intero complesso.