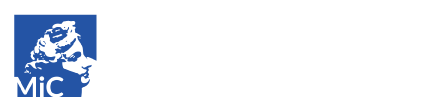Luogo: Falcade (BL), Via Scola, 34
Autore: Giuseppe Davanzo; Aldo Rampazzo (Collaboratore)
Cronologia: 1971 | 1972
Itinerario: La casa in Italia tra costruzione e sperimentazione
Uso: Abitazione studio / Museo

La casa di Augusto Murer oggi Casa Museo, sorge sul crinale che porta al punto più alto del comune di Falcade. Lo scultore, originario del posto, commissiona all’architetto trevigiano Giuseppe Davanzo la sua Casa Studio, imponendo alcune condizioni che l’architetto recepirà e tradurrà nel progetto. Le vicende della costruzione dell’edificio sono molto celeri: nel 1971, a seguito dell’incarico, è realizzato un progetto preliminare a cui segue il definitivo e il cantiere che si conclude nel 1972. L’architetto e lo scultore, a distanza di qualche anno, condivideranno un’altra esperienza: la progettazione e realizzazione del Monumento alla Resistenza Partigiana a Crespano del Grappa.
Murer scrive nel suo testamento che alla sua morte la casa-studio dovrà essere trasformata in museo, non tanto per celebrare la sua figura, quanto per realizzare un polo artistico-culturale nella città di Falcade. Nel 1986, ad appena un anno dalla morte di Murer, si tiene l’inaugurazione del museo, ancora oggi funzionante.

Giuseppe Davanzo, su richiesta del committente realizza un edificio che contenga ampi spazi per il lavoro e per l’esposizione delle opere. L’impianto è organizzato all’interno di una maglia quadrata di 4,40 metri per lato. Sfruttando l’orografia del terreno e la presenza di elementi vegetali la costruzione si sviluppa longitudinalmente, interrotta da un braccio trasversale che le conferisce la forma di una croce greca. Articolato su due elevazioni, il pian terreno ha una estensione ridotta rispetto al primo piano, lasciando quest’ultimo sospeso dal suolo per gran parte della sua estensione.

Davanzo si pone contemporaneamente in contrasto e in dialogo con la tradizione costruttiva locale. Rifiuta l’utilizzo del legno, tecnica predominante nel contesto alpino, parallelamente fa in modo che le tracce dei casseri risultino ben evidenti sulla superficie del calcestruzzo a facciavista. Lo stesso calcestruzzo è trattato con una pigmentazione scura, aggiunta alla miscela di preparazione, in modo tale da costruire un dialogo con gli alberi di larice già presenti nel sito.

La scansione interna degli ambienti è di tipo funzionale: al piano terra è collocato l’ingresso e trovano posto gli spazi di rappresentanza, un soggiorno per il ricevimento degli ospiti e un piccolo spazio espositivo. Al piano primo trovano posto i laboratori, distinti per tipo di lavorazione: un laboratorio per il gesso e uno per il legno. Infine, in uno spazio soprelevato a doppia altezza, trova posto il laboratorio di disegno, illuminato da due grandi lucernai verticali esposti a nord.

Il laboratorio di disegno, situato nello spazio a tutta altezza, aveva la duplice funzione di realizzare un ambiente isolato dai laboratori di scultura e di consentire un’osservazione dall’alto delle sculture realizzate in legno.

Le pareti dell’edificio appaiono quasi totalmente prive di bucature, il passaggio dell’aria è garantito dalla presenza di fori disposti in serie verticali e di finestre di piccole dimensioni dalla sagoma strombata. L’assenza di aperture affacciate sull’ambiente circostante deriva da una specifica richiesta dello scultore, il quale non riusciva a lavorare con la presenza incombente delle montagne circostanti.

Al fine di evitare il contatto visivo con l’esterno, l’illuminazione dei laboratori è garantita dalla presenza di lucernai verticali disposti a tetto, con andamento regolare, alla mezzeria di ogni modulo quadrato. Tutto il sistema delle coperture è caratterizzato da un rivestimento in lamiera rossa.


L’interno del primo piano, attualmente adibito a esposizione permanente delle opere dello scultore, è un ambiente unico senza divisioni verticali: la suddivisione originaria degli spazi funzionali – laboratorio del legno e del gesso – era scandita da una differenza di pavimentazione. L’illuminazione naturale proviene dai lucernari verticali disposti in copertura.

All’esterno trova posto una struttura in metallo per movimentare i grossi tronchi di legno che venivano selezionati dallo scultore per la realizzazione delle opere.
Foto di Marina Caneve
Testo di Luciano Antonino Scuderi