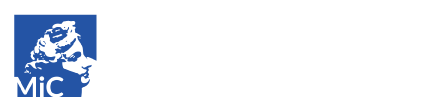Luogo: Bergamo, Via Guglielmo Mattioli, 57
Autore: Giuseppe Pizzigoni; Dietelmo Pievani (scultura dell’abside), Claudio Nani (Tabernacolo), Nino Marra (vetrate); Paolo Belloni (restauro)
Cronologia: 1961 | 1965 ; 2011 | 2014 (restauro)
Itinerario: Spazio sacro e memoria
Uso: Luogo di Culto

L’edificio si trova nel quartiere Longuelo alla periferia nord di Bergamo. Nel 19… Pino Pizzigoni, architetto di origini Bergamasche, già all’apice della carriera, viene incaricato dal vescovo Giuseppe Piazzi della redazione del progetto per una nuova chiesa, destinata a raccogliere il sempre maggiore numero di fedeli che si trasferivano nel quartiere in seguito alla realizzazione di diversi lotti da parte dell’INA Casa. Pizzigoni decide di sfruttare al massimo le potenzialità di un materiale duttile come il calcestruzzo armato, cimentandosi con la sperimentazione di una struttura complessa, composta da tiranti puntoni e volte sottili.

L’archetipo a cui l’architetto intende ispirarsi è la tenda di Mosè nel deserto: per ottenere la suggestione di una tenda realizza un complesso sistema di sostegni paliformi e di vele, tutti realizzati in calcestruzzo armato.

La chiesa è concepita come l’assemblaggio di quattro parti strutturalmente indipendenti tra loro. La suddivisione è ben evidente sui due fronti laterali, dove gli elementi che costituiscono l’ossatura portante sono esplicitati. Ogni blocco autonomo è composto da strutture lineari e membrane a doppia curvatura dallo spessore di cinque centimetri, già utilizzate dall’architetto in altri progetti, seppure in modo meno ardito.

Uno studio molto approfondito del sistema strutturale e della composizione dei materiali è stato affrontato nel corso del restauro eseguito tra il 2011 e il 2014, resosi necessario per l’eccessivo deterioramento del calcestruzzo, che rischiava di compromettere il buon funzionamento della complessa struttura. Il rilievo laser scanner e le indagini condotte nel corso del restauro hanno consentito l’acquisizione di numerose informazioni relative alle dimensioni degli elementi e in particolare agli spessori delle membrane.


La sperimentazione tecnico-strutturale condotta per la realizzazione dell’edificio è valsa a Pizzigoni significativi riconoscimenti da parte della critica, ma ha creato diverse difficoltà per quanto riguarda la conduzione del cantiere, non ultimo il problema di trovare un’impresa disponibile a dar vita al complesso progetto.

L’ingresso principale è definito da una membrana arcuata, originata dalla sagoma del portone e protesa verso l’esterno con una forte accentuazione della verticale, così da creare una sorta di invito all’accesso.

L’impianto centrale della chiesa consente un’immediata percezione di tutto lo spazio, che mostra, a differenza della tensione quasi muscolare dell’esterno, una morbidezza accogliente. Le convessità delle volte sottili in calcestruzzo sembrano gonfiate dal vento e avvolgono gli elementi di sostegno con naturalezza.

La luce proveniente dalle vetrate colorate, disposte nella porzione sommitale e non immediatamente visibili dall’aula, colora le superfici curve di calcestruzzo grezzo in modo differenziato, creando giochi chiaroscurali che enfatizzano le profondità e le articolazioni, cifra linguistica dell’autore.