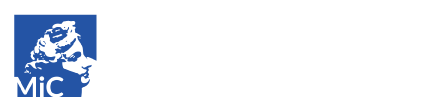Luogo: Rivoli (TO), Piazza Mafalda di Savoia
Autore: Andrea Bruno; Pier Carlo Poma, Vittorio Nascé (strutture)
Cronologia: 1979 | 1984
Itinerario: Costruire sul costruito –Nuove architetture per la nuova società – L’architettura contemporanea nel paesaggio
Uso: Museo

Quello che oggi vediamo dell’antico Castello di Rivoli è quanto resta della sontuosa residenza di Casa Savoia, che fin dal XIII secolo volle stabilire la propria corte in questa città.
Nel XVII secolo il duca Carlo Emanuele I dette l’incarico agli architetti Carlo e Amedeo di Castellamonte di trasformare il castello in una residenza di svago, facendo edificare anche la cosiddetta “Manica lunga”, un edificio di 147 metri di lunghezza e 6 metri di larghezza, destinato a ospitare la sua pinacoteca. L’edificio verrà completato nel 1670, ma tra il 1691 ed il 1693 il passaggio dell’esercito francese causò gravissimi danni al castello, tanto che di quel periodo rimase soltanto la sala di Amedeo VIII, ricca di affreschi.
Subito dopo, Re Vittorio Amedeo diede avvio a una fase di ristrutturazione e ingrandimento del castello, chiamando a corte, agli inizi del ‘700, Filippo Juvarra, tra i più importanti architetti barocchi d’Europa. L’architetto siciliano progettò un edificio sontuoso, degno di una corte di livello europeo, che però non verrà mai terminato, sia per gli alti costi di costruzione, sia a causa della prigionia del Re.
Dopo la morte di Vittorio Amedeo, iniziò una fase di decadimento dell’edificio, tanto che nel 1883 gli eredi dei Duchi d’Aosta lo vendettero al Comune di Rivoli, che lo trasformò, sino al 1909, in una caserma militare. Il castello fu profondamente danneggiato e devastato e danni ancora maggiori furono causati dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale.
Oggi il Castello si presenta con le sue parti settecentesche incompiute o rimaneggiate, la seicentesca “Manica Lunga” e l’atrio centrale, a cielo aperto, che unisce idealmente i due edifici.


Alla fine degli anni ’60 si inizia a parlare di un possibile recupero del castello: quello che restava dell’antica residenza sabauda, in uno stato di avanzato degrado, era il moncone dell’edificio dello Juvarra, l’atrio abbozzato e la Manica Lunga. L’architetto Andrea Bruno, incaricato di redigere i rilievi dello stato di fatto del Castello, elaborò i primi disegni, sebbene lo stato di abbandono dell’edificio continuò a produrre danni alle strutture fino al 1978, anno in cui crollò la volta del grande salone al secondo piano.
Per evitare ulteriori danni, la Regione Piemonte decise di intervenire al fine di restaurare l’edificio per destinarlo ad attività culturali. Fu tuttavia sotto la spinta del Conte Panza di Biumo, importante collezionista d’arte contemporanea, che prese corpo l’idea di allestire nel castello un museo di arte contemporanea, destinato a ospitare una parte della sua preziosa collezione.


L’incarico per il restauro del castello venne affidato all’architetto Andrea Bruno, il quale elaborò un progetto tale da “riportare l’edificio alla situazione del non finito, propria del cantiere incompiuto dello Juvarra” (A. Bruno), al fine di conservare tutte le parti superstiti dell’edificio, senza aggiunte o rifacimenti, “affinchè ogni cosa appartenente al tempo passato fosse mantenuta nella sua autenticità storica e artistica” (A. Bruno).
Inoltre le integrazioni necessarie all’edificio dovevano rispondere ai criteri della “reversibilità” e della “distinguibilità”, nonché servire a “mostrare l’architettura” e a “collegare le parti” (A. Bruno).

In primo luogo furono realizzati i lavori di recupero delle coperture delle parti superstiti dell’edificio, unitamente alle opere strutturali di restauro, al fine di ripristinare la stabilità della struttura dell’edificio, da anni in uno stato di abbandono e di decadenza.
In particolare fu ideata una passerella in struttura metallica sospesa sull’estradosso di una volta nervata in muratura, irrigidita con catene metalliche, particolarmente interessante da un punto di vista strutturale per la sua unicità compositiva. La passerella permette inoltre di osservare le capriate in cemento armato, costruite durante la guerra a seguito di un bombardamento che aveva distrutto il tetto dell’edificio, che riprendevano il disegno originale delle antiche capriate lignee e il sistema di orditura della copertura.


Uno dei problemi affrontati nel corso del restauro del castello fu rappresentato dell’assenza di un collegamento verticale delle parti dell’edificio, in quanto sia lo scalone progettato da Filippo Juvarra, sia la scala provvisoria progettata successivamente dall’architetto Carlo Randoni non erano mai state completate. Inoltre le opere provvisionali realizzate dai soldati durante l’uso a caserma dell’edificio erano del tutto inutilizzabili.

Per ristabilire una connessione tra i vari livelli, si decise di svuotare il vano scala e di posizionare all’interno dello stesso sia un ascensore che la scala di collegamento tra i piani. A tal fine fu demolita la scala randoniana (della quale resta traccia dal disegno in marmo nella pavimentazione dell’ingresso) e creata una nuova scala.
La prima parte di questa nuova scala, realizzata in cemento armato, corre lungo le pareti e giunge sino al primo piano, mentre le successive rampe risultano sospese all’interno del vano scala, in quanto costituite da una struttura in acciaio appeso tramite cavi a una trave metallica fissata trasversalmente ai pianerottoli in cemento armato di accesso ai vari piani. Ne risulta una struttura completamente reversibile e totalmente autonoma rispetto al sistema costruttivo dell’edificio.

Nella facciata ovest del castello è stata realizzata una bussola sospesa in corrispondenza di una precedente apertura presente nella parete. La bussola, nota come “belvedere panoramico”, è stata realizzata mediante il ricorso a una struttura portante in acciaio con pareti in cristallo e permette di apprezzare il contesto paesaggistico che circonda il castello.

Nella Manica Lunga è stata ripristinata la composizione architettonica dei prospetti, sono state eliminate le partizioni interne della galleria del piano nobile ed è stata sostituita la struttura lignea portante della copertura, ormai distrutta, con una struttura metallica.
La testata dell’edificio lungo il versante est, originariamente tamponata con pareti in mattoni, è stata chiusa con vetrate che mettono in evidenza la partizione dei piani con volte a botte e consentono di dare una maggiore illuminazione agli ambienti interni.

Il sistema dei collegamenti verticali è stato risolto mediante la realizzazione all’esterno dell’edificio, e chiaramente connotati come interventi moderni e reversibili, di tre copri scala e ascensore lungo il fronte nord, realizzati in calcestruzzo armato a vista, acciaio e specchiature vetrate. In adiacenza della testata ad est, invece, è stata realizzata una scala in mattoni facciavista che consente l’accesso al primo piano della “manica lunga”, da dove si dipartono i percorsi orizzontali interni.

La copertura della “manica lunga” è stata realizzata ex novo, riprendendo il disegno di quella esistente, mediante una struttura metallica connotata dalla visibilità delle centine poste a sostegno della calotta centrale che si estende per tutta la lunghezza dell’edificio; le falde sono interrotte da due lunghe vetrate poste lungo l’attacco alle pareti, tali da consentire una maggiore illuminazione dell’ambiente interno, anche in funzione del sistema espositivo delle opere.