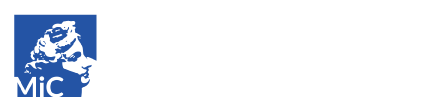Luogo: Ivrea (TO), Quartiere la Sacca, via Torino 217
Autore: Giovanni Klaus Koenig; Claudio Messina (strutture)
Cronologia: 1963 | 1970
Itinerario: Spazio sacro e memoria
Uso: Edificio per il culto

La chiesa Valdese, collocata sull’asse di via Torino nel quartiere la Sacca, sul versante est della città, rappresenta uno dei tasselli del progetto olivettiano per Ivrea. L’edifico sorge infatti su un terreno acquistato dalla ditta Olivetti nei primi anni Sessanta e costruita in parte con fondi messi a disposizione dalla stessa, ai quali si aggiungono somme raccolte da altre organizzazioni religiose. Il progetto è affidato all’architetto Giovanni Klaus Koenig, torinese di nascita e laureatosi a Firenze, e all’ingegnere Claudio Messina. Il tema affrontato non è nuovo per i progettisti, i quali ricevono committenze da parte della Tavola Valdese per la realizzazione di chiese in tutta Italia, da Genova a Pinerolo a Palermo.

Oltre alla particolare affinità con il linguaggio di Koenig architetto legata al tema progettuale, l’edifico presenta altre caratteristiche del suo lessico. In primo luogo, la dimensione contenuta: nel corso della sua carriera di progettista, Koenig realizza edifici d’abitazione per lo più unifamiliari, piccole scuole ed edifici di culto (Messina 1994). In secondo luogo, l’affinità con il linguaggio espressionista olandese a lui molto caro (Bonifazio, Giacopelli 2007) e al quale, in veste di critico e studioso, dedica numerosi studi.

L’ingresso principale è collocato su via Torino, ortogonalmente all’aula liturgica alla quale si accede attraversando un piccolo atrio, oggi chiuso da un infisso. L’aula, così come il resto della costruzione, presenta una forma irregolare e asimmetrica enfatizzata dalla presenza di una galleria, realizzata per aumentarne la capienza. Le linee spezzate, che contribuiscono alla definizione spaziale degli ambienti, contrastano con la morbidezza delle forme esterne, caratterizzate da volumi smussati e spigoli arrotondati.


Gli arredi interni, Pulpito, Tavola per la Santa Cena e Tabella per gli Inni, sono progettati dallo stesso Koenig e realizzati in legno. Le sorgenti di luce naturale sono ben celate e consentono di ottenere un interessante contrasto tra la luminosità degli spazi interni e la quasi totale assenza di finestre. La zona presbiterale si presenta totalmente cieca ma illuminata da un lucernario verticale posto al di spora dell’altare. Finestre e lucernari sono collocati anche al piano della galleria e una vetrata orizzontale consente l’ingresso della luce alle spalle degli astanti.


Il lotto su cui è realizzato l’edificio presenta un dislivello assorbito dalla realizzazione di ambienti di servizio alla chiesa. Oltre alla funzione liturgica, trovano posto numerosi spazi aggregativi per la comunità. Tali ambienti sono sviluppati attraverso l’aggregazione di volumi che definisce spazialmente la configurazione del retro. Il trattamento uniforme delle superfici esterne, rivestite in cortina di mattoni rossi, enfatizza la lettura della giustapposizione dei diversi volumi, distinguendo in modo netto l’edificio dal contesto edilizio di tipo prettamente residenziale.


Il lavoro sul controllo dei volumi in rapporto allo spazio interno è condotto dai progettisti attraverso un accurato lavoro di verifica e revisione di tutte le superfici. Tale lavoro ha previsto l’utilizzo non soltanto di disegni ma anche di modelli tridimensionali, che meglio si prestano alla verifica di combinazioni volumetriche complesse (Messina 1994).