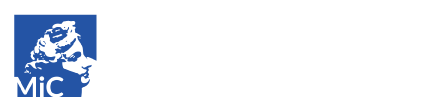Luogo: Arzachena (SS), Costa Smeralda, Via Stella Maris
Autore: Michele Busiri Vici, Luciano Minguzzi (portale bronzeo)
Cronologia: 1966 | 1968
Itinerario: Architetture Riflesse – Spazio sacro e memoria
Uso: Chiesa

Situata in località Porto Cervo, inserita nel più ampio progetto architettonico realizzato negli anni Sessanta dal Consorzio Costa Smeralda, La Chiesa Stella Maris è parte del quartiere denominato “Sa Conca” progettato da Michele Busiri Vici. L’architetto romano, già presente in Sardegna nei primi anni Venti del Novecento al fianco del padre Carlo, negli anni Sessanta entra a far parte del gruppo di architetti, composto tra gli altri da Luigi Vietti, Raymond Martini e Jacques Couelle, che si occuperà della realizzazione del programma architettonico, a prevalente vocazione turistica, voluto dal Consorzio Costa Smeralda e formalizzato nel 1962, che annovera tra i soci il principe Aga Khan Karim IV. Proprio grazie al Principe, che donerà il terreno su cui sorge la costruzione, e alla volontà del vescovo Giovanni Melis Fois, sarà avviato l’iter di progettazione della parrocchiale Stella Maris, primo edificio pubblico e unico edificio di culto del complesso turistico.

La chiesa è rappresentativa del linguaggio adottato per la realizzazione di tutto il complesso, declinato diversamente dai vari attori, ma segnato da caratteristiche invarianti di uno “stile mediterraneo” inventato in conformità a una lettura e reinterpretazione dell’architettura tradizionale sarda. L’edificio presenta, debitamente rielaborate, alcune delle caratteristiche delle chiese campestri tradizionali diffuse in Sardegna, tra questi il portico risolto con una tettoia lignea sostenuta da blocchi megalitici in granito grezzo. Nello specifico caso, il portico segue l’andamento leggermente concavo della facciata, accompagnato dalle sagome curvilinee del coronamento che nascondono i due spioventi del tetto.

Il fronte sud anticipa l’articolazione interna dell’edificio. In primo piano, la torre campanaria definisce l’angolo della facciata rastremandosi verso l’alto, presenta una pianta ellittica all’interno della quale trova posto il battistero dotato di un ingresso indipendente collocato sul fronte principale. Il campanile introduce la sequenza di tre volumi cilindrici che compongono la navata laterale della chiesa, l’insieme di volumi che definisce la zona absidale e il collegamento con la casa canonica posto al piano sottostante. Tutto il complesso presenta la tradizionale copertura con tegole in cotto e terminazioni di ferro battuto.

Anche l’interno presenta citazioni della tradizione locale: l’impianto è articolato su due navate, la principale scandita da tre campate, coperta da una volta ribassata, l’unica navata laterale di ampiezza corrispondente a un terzo rispetto alla principale e da questa separata per mezzo di diaframmi ad archi impostati su pilastri dalle forme arrotondate.
Particolarmente rilevante lo studio dei dettagli tipico delle architetture di Michele Busiri Vici, come il pavimento realizzato con la composizione di grosse fette di granito, le acquasantiere ricavate da grosse conchiglie e i lampadari metallici che scandiscono lo spazio, da lui stesso disegnati.

In corrispondenza della controfacciata è concentrato un complesso sistema di ambienti dedicati alle diverse funzioni liturgiche. Al centro, un piccolo vano dai bordi smussati funge da diaframma con l’esterno, contenendo il portone di accesso all’aula. Rivolgendo le spalle all’altare, l’ingresso è incorniciato a destra da un piccolo confessionale e a sinistra dall’acquasantiera e dalla scala che conduce alla cantoria posta in asse con il portone principale. Sulla sinistra, in corrispondenza della navata laterale, trova posto il battistero.

Le tre campate di forma circolare che costituiscono la navata laterale presentano coperture a calotta emisferica intervallate da spazi di diaframma che contengono i sostegni verticali delle volte. All’interno di uno di questi spazi-diaframma trova posto l’accesso laterale all’edificio.

Il portale laterale, realizzato in bronzo, è opera dello scultore bolognese Luciano Minguzzi, già autore della quinta porta del Duomo di Milano (1965) e successivamente della Porta del Bene e del Male per la Basilica di San Pietro in Vaticano (1970).

L’edificio destinato al culto seppur piccolo e molto raccolto, incarna perfettamente il linguaggio dell’architetto romano, l’assenza di spigoli la preponderanza di superfici smussate e di elementi arrotondati, accostate all’utilizzo di materiali declinati dalla tradizione locale come il granito e l’intonaco bianco concorrono alla realizzazione dell’immagine veicolata dal progetto originario del consorzio “Costa Smeralda”.