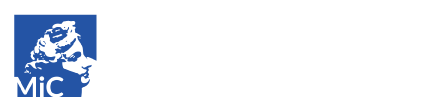Luogo: Muda Maè, Longarone (BL)
Autore: Gianni Avon, Francesco Tentori, Marco Zanuso, Jane Wernick Associati (strutture)
Cronologia: 1966 | 1972
Itinerario: L’architettura contemporanea nel paesaggio – Spazio sacro e memoria
Uso: Luogo di culto

Il cimitero comunale di Longarone, originariamente in prossimità della città, viene spostato in località Muda Maè a seguito dell’inondazione che distrugge gran parte dell’abitato, cimitero compreso, nella notte del 9 ottobre 1963.
Il sito prescelto si trova a quota molto più alta rispetto al centro abitato e fronteggia la valle del Vajont, all’interno della quale è ancora ben visibile la sagoma della diga.
Gianni Avon, già attivo nel dibattito sulla ricostruzione del centro distrutto dalla catastrofica inondazione, riceve l’incarico per la progettazione del nuovo cimitero direttamente dal genio civile nel 1966. Sarà lui stesso a coinvolgere i colleghi Francesco Tentori e Marco Zanuso, con i quali aveva già condiviso esperienze di progettazione.

Il sito prescelto è un pianoro che interrompe il costone montuoso della val Zoldana, prospicente il torrente Maè. Gli spazi del cimitero si sviluppano longitudinalmente, articolandosi con una successione di elementi geometrici ricavati dallo scavo del terreno. Gli ossari, contraddistinti dalla forma circolare, segnano l’accesso al percorso delle sepolture, il punto mediano e il punto finale.

Il percorso scavato in trincea asseconda l’andamento del terreno leggermente acclive, i salti di quota sono accompagnati da piccole rampe di scale, corrispondenti a cambi di sezione del percorso. Le pareti della trincea ospitano i loculi, le cui chiusure sono realizzate con elementi in calcestruzzo prefabbricato.

Il percorso scavato in trincea asseconda l’andamento del terreno leggermente acclive, i salti di quota sono accompagnati da piccole rampe di scale, corrispondenti a cambi di sezione del percorso. Le pareti della trincea ospitano i loculi, le cui chiusure sono realizzate con elementi in calcestruzzo prefabbricato.

Le pareti di contenimento che definiscono lo scavo sono realizzate in pietra locale a spacco assemblata a secco, i collegamenti tra la quota del pianoro e il piano delle sepolture si trovano distribuiti in otto punti lungo tutto il percorso, in modo tale da poter rendere fluida la fruizione dello spazio.


Le pareti di contenimento che definiscono lo scavo sono realizzate in pietra locale a spacco assemblata a secco, i collegamenti tra la quota del pianoro e il piano delle sepolture si trovano distribuiti in otto punti lungo tutto il percorso, in modo tale da poter rendere fluida la fruizione dello spazio.


Il percorso, a prevalente andamento longitudinale, presenta restringimenti e dilatazioni della sezione. Queste ultime costituiscono dei luoghi di sosta all’interno dei quali il lastricato in pietra si interrompe, lasciando spazio a delle aiuole e a delle sedute affiancate ai muri di contenimento.


Gli unici oggetti, emergenti dalla quota di calpestio del pianoro, sono alcune sepolture a terra, raggiungibili da un percorso in quota parallelo allo scavo e un volume a forma di cilindro cavo adibito a sepolture private.