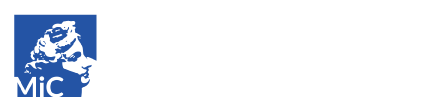Luogo: Napoli, Fuorigrotta, Via Guglielmo Marconi, 9
Autore:
Riccardo Avolio De Martino, Mario De Renzi, Raffaele Contigiani; Guido Mele, Giuseppe Sambito (strutture); Raffaele Scorzelli (sculture fontana)
Itinerario: Nuove architetture per la nuova società
Cronologia: 1958 | 1963
Uso: Centro di produzione televisiva
Itinerario: Nuove architetture per la nuova società

La progettazione dell’edifico è affidata a un gruppo di architetti, al cui interno le figure più note sono quella di Riccardo Avolio De Martino, a cui probabilmente si devono gran parte delle scelte, milanese di nascita ma campano di adozione, autore di numerose importanti realizzazioni, sia pubbliche che private, ubicate principalmente nella città di Napoli, e quella di Mario De Renzi, attivo a Roma e qui alla sua prima opera partenopea (E. Carreri 1994). L’edificio è composto da cinque blocchi funzionali. Il grande auditorium, utilizzato per numerose trasmissioni televisive, definisce con il blocco che ospita l’ingresso una corte, all’interno della quale campeggia la scritta “RAI Radiotelevisione Italiana” fissata su un pannello murario realizzato con pannelli in terracotta traforati che lo rendono permeabile alla luce naturale.

Inserito nel contesto del quartiere Fuorigrotta di Napoli, il Centro di produzione RAI contribuisce alla radicale trasformazione urbana e sociale della zona su cui insiste.
Già interessato dalla costruzione della Mostra d’Oltremare, il cui impianto originale è di qualche decennio più vecchio, dalla realizzazione dello Stadio San Carlo e della Facoltà d’Ingegneria, il quartiere, tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta, si arricchisce di nuove funzioni e nuovi poli attrattivi. Il centro di Produzione rappresenta un’importante novità per la città di Napoli: si tratta di uno tra i primi centri di produzione, preceduto da quelli di Milano, Torino e Roma; si estende longitudinalmente lungo la via Marconi con una complessa alternanza di volumi che ne denunciano la complessità dell’organizzazione e la varietà delle attività svolte all’interno.

Il blocco degli uffici è il più alto sul fronte strada, contraddistinto dalla presenza delle antenne che, congiuntamente alle scritte, oltre a denunciare la funzione degli edifici RAI, ne diventano elemento distintivo. Il volume di pianta rettangolare si eleva per sei piani fuori terra, l’ultimo occupato da volumi tecnici. Le due testate sono occupate dei corpi scala, graficamente individuati, sulle pareti esterne completamente cieche, da fasce marcapiano che seguono l’andamento dei solai e delle rampe, interrompendo l’uniformità del rivestimento in klinker color rosso bruno. I prospetti principali dell’edificio sono realizzati con elementi in alluminio e vetro che ne smaterializzano la consistenza, enfatizzando la maglia strutturale e garantendo un’ottima areazione e illuminazione naturale degli ambienti interni. All’interno del cortile, in posizione decentrata, è collocata la Fontana del Guarracino (attualmente non in funzione), le cui sculture raffiguranti pesci e i bassorilievi bronzei sono opera dello scultore napoletano Raffaele Scorzelli.


Il complesso, così come gli altri centri di produzione RAI realizzati in Italia, presenta interessanti innovazioni dal punto di vista tecnologico. Al suo interno si svolgono lavori molto differenziati e opera un gran numero di persone: oltre all’auditorium, alle sale di registrazione e agli uffici dell’amministrazione, sono presenti ambienti di servizio per i lavoratori, quali la mensa e la cappella e diversi spazi di accoglienza e di rappresentanza atti a ospitare le varie personalità che passavano dagli studi.

Oltrepassato l’ingresso, si accede a una delle due rampe di distribuzione del blocco uffici. Internamente, così come esternamente, la progettazione dell’edificio coniuga geometrie molto rigorose, enfatizzate da materiali classici quali il legno e il cristallo con cui è realizzato il corrimano della scala, a episodi di spiccata ricerca formale e tecnologica, come gli infissi che chiudono lo spazio dei pianerottoli, realizzati con una sorta di bow-window, che si ripete a tutti i piani.



Le pareti vetrate dei due corpi scala sono installate in corrispondenza dello spigolo nord-ovest e dello spigolo sud-est del blocco uffici, il più alto di tutto il complesso. Procedendo verso l’alto, grazie alla superficie interamente vetrata si possono osservare il panorama sul quartiere di Fuorigrotta (dal fronte ovest) e la mostra d’Oltremare (dal fronte est). L’infisso, dalla particolare configurazione geometrica, è composto da tre livelli realizzati grazie all’assemblaggio di pezzi modulari: un parapetto verticale fisso, una stretta fascia centrale apribile per il ricambio d’aria e infine un pannello superiore inclinato fisso. Di particolare interesse la soluzione di attacco con le pareti laterali arretrate rispetto all’aggetto dei solai.


Le finiture e gran parte degli arredi originali sono tutt’oggi in uso. Particolarmente interessanti alcuni accostamenti cromatici, realizzati grazie alla scelta delle finiture ed enfatizzati da complementi d’arredo come corpi illuminanti e sedute per le sale d’attesa.

L’accostamento dei diversi blocchi funzionali è studiato in modo da poter ricavare spazi aperti collocati a diverse quote. Tra l’atrio d’ingresso, il palazzo degli uffici e le sale di registrazione si sviluppa un grande cortile, al di sotto del quale, sfruttando il dislivello del terreno, trovano posto parcheggi e magazzini. La grande corte quadrata aperta su un lato prosegue con una passerella in quota che collega gli altri spazi funzionali dell’edificio con l’atrio d’ingresso.

Il tema dei collegamenti tra i diversi blocchi che compongono il complesso è risolto con un interessante sistema di passaggi aerei completamente vetrati. Le passerelle sono direttamente accessibili dal blocco uffici e si sviluppano con struttura autonoma, collegando il blocco mensa, il blocco degli studi radiofonici e gli studi televisivi, costeggiandone le pareti.

L’auditorium Domenico Scarlatti, attualmente oggetto di lavori, costituisce uno degli elementi più rappresentativi dell’edificio, sia dal punto di vista simbolico che dal punto di vista architettonico. L’edificio presenta una sala per il pubblico a forma di ventaglio, realizzata con una struttura in cemento armato inclinata, sotto alla quale trovano posto il foyer e l’ingresso. Tutto il blocco è realizzato con sette grandi travi in cemento armato sorrette da altrettanti setti sul fronte strada e sul retro della scena. La platea è in grado di contenere fino a mille persone e sul fondo-scena è installato un grande organo a canne, all’epoca della costruzione il più grande d’Europa.